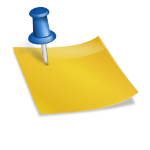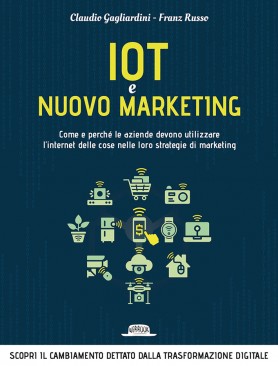Comunicazione: cosa dovremmo imparare dall’emergenza COVID-19

Negli ultimi 30 anni il mondo è cambiato come mai era accaduto in passato. Le epidemie non sono una novità, ovviamente, ma gli strumenti di comunicazione, relazione e condivisione di cui oggi disponiamo non c’erano nemmeno ai tempi della SARS, poco meno di 20 anni fa. Nel frattempo il mondo si è radicalmente trasformato: non sono più gli stessi i media, gli strumenti, i canali e anche la società ha subito enormi mutamenti, così come i suoi rappresentanti politici, gli opinion leader (che oggi chiamiamo per lo più influencer), le istituzioni e i loro vertici. Oggi la comunicazione non piove più dall’alto, ma si determina, si costruisce e si propaga da e verso molteplici direzioni, ingenerando fenomeni difficilmente controllabili, come la piaga delle fake news nelle sue diverse e varie sfumature.
In questo nuovo contesto un’emergenza a carattere mondiale come quella del Coronavirus COVID-19 diventa un banco di prova fondamentale, cui il nostro sistema informativo ha retto malissimo, mettendo in luce molti dei limiti di un ecosistema di comunicazione così vasto, aperto e difficile da gestire. Tra allarmismo, catastrofismo, bufale di ogni genere e messaggi travisati o rimaneggiati, spesso in modo doloso, ci sono però lezioni importanti che non dobbiamo sottovalutare e che ci possono aiutare ad evolvere in una direzione più sostenibile.
L’incubo del virus e la sua comunicazione
Sembra impossibile che, per l’ennesima volta, il nostro sistema di comunicazione e di informazione si sia fatto trovare così impreparato di fronte ad un’emergenza annunciata, di cui si parlava diffusamente già da oltre un mese prima che arrivasse in Italia.
Eppure, ancora una volta, in un qualsiasi venerdì di febbraio dell’anno “bisesto” 2020 abbiamo dovuto imparare ancora una volta che “la Cina è vicina” e che le scene surreali della città di Wuhan, megalopoli da 11 milioni di abitanti, potevano riguardare il mondo intero e in primo luogo il nostro Paese.
Così, all’indomani dei primi ricoveri a Codogno e dintorni, in un’area da poche decine di migliaia di persone, i media italiani hanno scatenato uno psicodramma che ha imperversato su tutti i mezzi e tutti i canali per settimane e per mesi, scatenando un’infodemia ben più virale e insidiosa del COVID-19 stesso. Un flusso interminabile di informazioni inquinate dal sensazionalismo, dal protagonismo, dalla politica e da infiniti interessi e sovrastrutture, il cui impatto ha trasformato quei cluster di informazione in comodi ingredienti per viralissime fake news, pronte a infestare la Rete e a creare ulteriore caos e problemi, peraltro contribuendo all’idea iniziale che si stesse esagerando e che in fondo la cosa non fosse poi così grave. Errore madornale.
L’11 settembre dell’informazione
Dopo quel venerdì di presa di coscienza collettiva, mentre il virus dilagava e iniziavano ad essere registrate le prime vittime, a giacere in coma e senza alcuna speranza sembrava essere proprio l’informazione. Dopo questa prova, una volta che avremo sconfitto i presagi più pessimisti e le priorità dell’emergenza, ridefinire le regole e i parametri di questo settore vitale sarà doveroso e altrettanto urgente.
Probabilmente non sapremo mai se le misure messe in atto dal nostro sistema sanitario saranno state le migliori possibili, né sapremo cosa sarebbe stato se non avessimo isolato in una zona rossa Codogno e altre aree ad alto tasso di infezione e poi chiuso in lockdown l’intero Paese, ma una cosa è certa: se l’impatto di queste misure poteva essere in qualche modo sostenibile, sia per le persone che per l’economia delle aree interessate, i danni collaterali del relativo bombardamento mediatico hanno colpito tutto il Paese e sortito effetti devastanti sull’economia nazionale, che si rifletteranno a lungo su tutti i settori e in tutti gli ambiti, in primis quello turistico.
Dopo Codogno, l’Italia è stata oggetto di immediato isolamento da parte di molti Paesi, nonostante all’inizio si registrassero soltanto piccoli focolai locali, immediatamente limitati e prontamente contenuti. Nel giro di pochi giorni il nostro Paese ha eguagliato la Cina nella percezione globale del pericolo COVID-19 e dei Paesi ad esso correlati.
Un danno enorme dovuto non tanto alla situazione contingente, ma al delirio comunicativo che ne è seguito, cui hanno contribuito certamente i media, ma a cascata anche la politica, il mondo dello spettacolo, della cultura e ogni singolo cittadino dotato di un account social su cui rovesciare le proprie paure, ansie e considerazioni non richieste.
Altrettanto insostenibile la comunicazione della Fase 2, che tutt’oggi ingenera confusione, dubbi, incertezza e difficoltà nel guardare il presente e il futuro in modo sereno e costruttivo. C’era e c’è ancora caos su tutto: sull’utilità di mascherine e guanti, sui test sierologici, sui tamponi, sulle regole da seguire ma, soprattutto, ognuna di queste incertezze sono quotidianamente strumentalizzate a fini politici, speculativi e personalistici. L’uso della mascherina, inizialmente sconsigliata a chi non fosse effettivamente malato o avesse avuto contatti con persone infette o ambienti a rischio, è oggi una sorta di meme o di argomento qualificante per chi ne fa uso o per chi la contesta. Le argomentazioni di medici ed esperti fanno da contorno ad un gigantesco dibattito in cui qualsiasi informazione diventa inevitabilmente opinione, appiglio comunicativo, pretesto.
Tutto questo non dovrà più accadere in futuro. Ecco perché occorre ripensare il modello della comunicazione e dell’informazione e imporre paletti chiari che valgano, sia pur in modo differente, per tutti gli attori di questo gigantesco flusso.
Foto di Colin Behrens da Pixabay